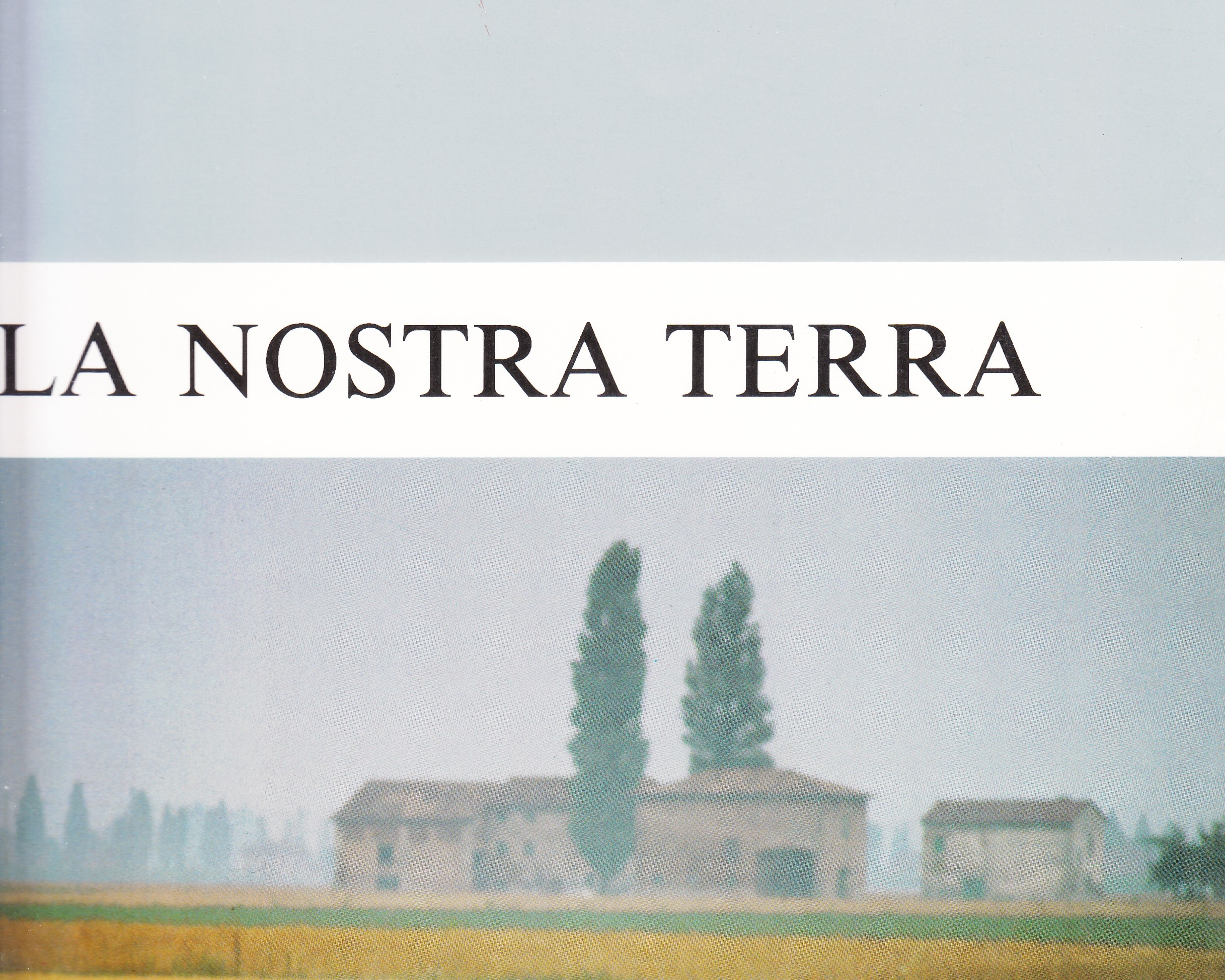La Bassa – Una terra tra mito e realtà
LA BASSA – UNA TERRA TRA MITO E REALTÀ
L’uomo della pianura non ha mai goduto di buona stampa. Specialmente quello della Bassa. La problematicità dell’esistenza in tale situazione ambientale, la scarsa informazione, la dipendenza di chi vive in una terra di confine, tutte queste componenti hanno creato, nel tempo, un’immagine distorta, scarsamente documentata dell’uomo che il destino ha posto nella terra tra i due fiumi. La sua immagine, quindi, spesso è viziata dal pregiudizio. Che quanto più è antico, tanto più è dura a morire. Soprattutto se esso viene rincalzato e sottolineato in opere di grande clamore. Com’è accaduto all’inizio del Seicento. Nella “Secchia Rapita”. Tra le rime del Tassoni. Che, per la verità, non ha usato la consueta, graffante ironia, ma s’è limitato a registrare il luogo comune, la considerazione largamente diffusa in Modena capitale:
“Le ville de la Motta e del Cavezzo,
Camposanto, Solara e Malcantone
Quivi raccolto avean la feccia e ‘l lezzo
D’ogni omicida rio, d’ogni ladrone;
Quel clima par da fiera stella avvezzo
A morire o di forca o di prigione.
Fur cinquecento, usati al caldo, al gielo,
A l’inculta foresta, al nudo cielo.
“San Felice, Midolla e Camurana
Seicento a piedi e ottanta erano in sella;
Nerazio Bianchi e Tomasin Fontana
Gli conduceano a la tenzon novella.
Tomasin per insegna avea una rana
Armata con la spada e la rotella:
Nerazio, che reggea quei da cavallo,
Avea una mezza luna in campo giallo.
S’armò dopo costor quella riviera
Che da Bomporto a la Bastia si stende:
Povera gente, ma superba e altera,
Che ‘n terra e ‘n acqua a provechiarsi attende.
Fur quattrocento: e ne la lor bandiera,
Che di vermiglio d ‘or tutta risplende,
Ritratto avea un gonfietto da pallone
Bagarotto figliuol di Rarabone”.
Come si vede nelle ottave tassoniane sono annotate molte delle “debolezze” di questa gente. Riportate col metro distorto di un nobile che viveva l’aristocratica realtà cittadina. Che aveva solo sentito parlare delle lontane terre difficili, abitate da uomini altrettanto difficili. Insomma un cronista che, se pur diligente, ha preso per buona la generalizzata diceria su pochi aspetti clamorosi. Le punte di un iceberg molto più esteso nella sua composita realtà. Scriverà Dario Zanasi che di tutte le terre della pianura solo la “sua” gente scamperà allo spietato giudizio tassoniano : “…di Sassol la gente/Che suol de’ l’uve far nettare a Giove”
Si diceva del pregiudizio. Il riferimento del poeta della “Secchia” alla “rana” offre il pretesto per sottolineare come i luoghi comuni nascano da esperienze e consuetudini di vita. Che poi, per significato traslato, assurgono a definizione di un popolo. Il mestiere del “ranaro” (quanta tassoniana carica ironica nel termine!) è antico, documentato nella sua piena dignità di lavoro duro. Ce lo attesta don Francesco Gavioli, cantore della Bassa, che lo definisce proprio un “mestiere per vivere”. Riportando un prezioso e minuzioso diario tenuto da un famoso“ranaro” della Mirandola. Una sorta di registro di carico e scarico ante litteram. Nell’Ottocento. Tante centinaia di migliaia di rane pescate nel tal’anno, corrispondenti a tante centinaia di lire modenesi. E questo per una vita intera. Scrive don Francesco: “La pesca avveniva nei fossati, nei maceri e nelle valli del Mirandolese, Ferrarese, Mantovano e Bolognese. Gli strumenti erano molto semplici: canne con appeso un filo assai robusto alla cui estremità veniva applicato un amo formato da un batuffolo di seta di bavella. Oltre alle canne si servivano del cosidetto retino composto di un lungo o corto bastone, secondo il luogo dove si pescava. Le rane venivano vendute nei giorni stabiliti di magro ed in modo particolare alle vigilie. Il fegato veniva smerciato sul mercato, il grasso bollito posto in anfore di terracotta verniciate in giallo in attesa di essere venduto come farmaco per guarire il male della sciatica. La vita di questi pescatori era soggetta alla malaria, per i luoghi poco salubri ove avveniva la pesca, specie nelle valli con acque stagnanti. Essi erano tenuti per la pesca lontani dai loro familiari ed il lavoro non era certo uno dei più comodi perché tante volte provavano delusioni ed incappavano in dolorose incognite”.
C’è in quell’ultilizzo del grasso di rana per la sciatica l’ indicazione sussurrata a quella linea impalpabile che marca il passaggio tra credenza e medicina, tra magia e realtà. Che richiede la fettuccia rossa contro il malocchio, che non vuole vedere il pane capovolto, che vuole la “segnatura” contro la distorsione lieve, ma su quella grave, dolorosa non può esimersi dell”‘averta”. Ancor oggi ampiamente praticata sulla nostra terra. Scrive, nell’Ottocento, Paolo Riccardi: “Sotto questo nome, non traducibile con esattezza (alla lettera – averta – significa – aperta -, fer l’averta – equivarrebbe a compiere l’apertura), passa presso il popolino nostro di città e di campagna, una operazione-scongiuro-esorcismo, destinata a guarire distorsioni, sciatiche, contusioni, nevralgie, ecc. presso uomini ed animali. Poche persone, a detta di chi vi crede, sono in grado di compiere l’operazione, e da quanto ho inteso non mi pare che i procedimenti di alcuni fortunati operatori siano simili fra di loro. Una di queste medichesse andava dicendo che l’arte dell’averta non potevasi insegnare che nella sera del Santo Natale e ad una persona nata di sette mesi. Per i suoi interventi faceva bollire un certo filtro, facendo su’l vaso dei segni e delle croci mediante pezzetti di vite d’uva bianca; e rovesciava l’acqua in un piatto per modo che il liquido risaliva nel vaso! Con detto liquore bagnava la parte offesa”.
A mezza via tra la sopravvivenza pagana e la mediazione sociale sta, o meglio stava, la “Filippa”, originale figura della nostra terra. Ormai definitivamente scomparsa nel grande naufragio delle antiche tradizioni. Ce la ricorda Franco Bisi: “Nella zona triangolare che va da Carpi a Soliera e Campogalliano, il nome Filippa” è vocabolo attribuito alla donna che segue con impegnato interesse un matrimonio imminente. Esso assume una accezione comune ed è pacificamente accordato alla donna che svolge il ruolo di onesta paraninfa, seguendo lo sviluppo di un amore e cooperando al suo coronamento. Il dì delle nozze dunque, a buon diritto, la leale pronuba s’accolla l’ufficio di zelante coordinatrice, di vigile animatrice, di consigliera ben informata, di solerte cerimoniera. A conclusione del buon operato la corretta mezzana riceveva in dono un paio di calze gialle”.
La nostra terra ha saputo, nei secoli, creare personaggi a tutto rilievo. Una gente tanto ricca di fantasia e concretezza da potersi davvero definire popolo. Da concepire primati con prodotti allevati su di una terra tanto difficile da identificarsi, per antonomasia, con la fatica. “La téra l’é bàsa!”la terra è bassa!, si deve piegare la schiena per lavorare la terra! Il vino, per esempio. Quel canonico Lambrusco che Dario Zanasi, in una chiara giornata d’inverno, assaggiò nella canonica del prete di Sorbara, “Sorbara è un nome aperto, armonioso, sonoro. Un nome felice che sembra derivare dalla sostantivazione del verbo sorbire, che significa bere a piccoli sorsi, aspirando leggermente. E infatti Sorbara è la famosa capitale del lambrusco. È il toponimo che ci indica quel vino chiaro, quasi evanescente, frizzante, dalla schiuma che sparisce rapidamente così come una goccia d’acqua su una lastra infuocata…” Ha confermato l’antica, settecentesca annotazione del Caula, “dietro al corso dei fiumi Secchia e Panaro, per essere le acque correnti, e i terreni di legger’arena, l’aria e le uve sono buone, come la Lambrusca del Nonantolano, le tre Ville di Solara, Sorbara, Sanprospero, poste tra Secchia e Panaro, fino al territorio di Camposanto e di Sanfelice esclusivamente”. Come si vede, un mosaico di valori che è bene non disperdere. Un’esistenza oggi più facile, ma anche più piatta ed immiserita di reali interessi, nasconde il reale pericolo dell’oblio e della dimenticanza per quell’ormai inesistente contatto con le situazioni che determinarono tanta ricchezza di tradizioni. Socialmente è bene, è giusto che sia così. Emotivamente il cuore, il nostro cuore di gente che pur vive su quella terra, batte più piano, con altro ritmo. Tuttavia non può tanto inaridirsi da estraniarsi all’adesione, al ricordo di un mondo che rappresenta pur sempre le radici profonde della nostra esistenza.
Tratto da: LA NOSTRA TERRA
Autori: Renato Bergonzoni – Beppe Zagaglia
Anno 1983