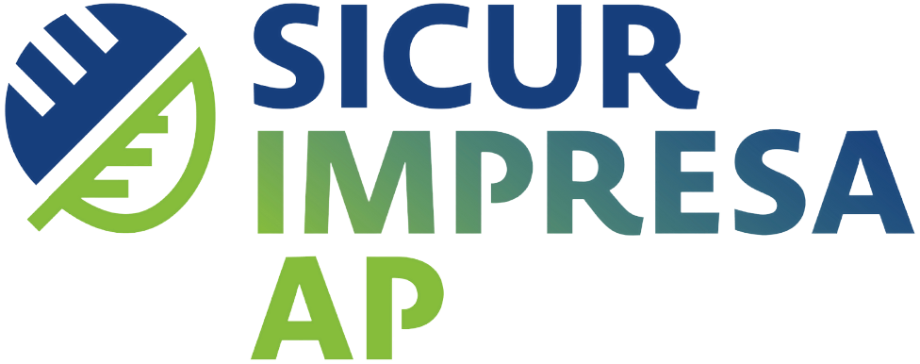Giovedì Grasso – “Ungere lo sprocco”
Disegno di Aleardo Cavicchioni

“UNGERE LO SPROCCO”
Almeno nella “Bassa”, i due giorni più importanti del Carnevale erano l’ultimo giorno del Carnevale stesso (cioè il martedì che precede il giorno delle sante Ceneri) e il “giovedì grasso”, vale a dire l’ultimo giovedì che precede la Quaresima.
L’ultimo di Carnevale era patrimonio degli adulti, poiché la serata comprendeva il tradizionale veglione più o meno mascherato. Ma attenzione: per non cadere nel peccato mortale, si poteva ballare e divertirsi fino alla mezzanotte, perché quando a mezzanotte in punto i campanili delle chiese facevano risuonare i rintocchi delle campane a morto che annunciavano le sacre Ceneri, bisognava smettere di ballare e di suonare e ognuno tornava a casa propria. Qualche “sacrilego” continuava a danzare, grazie a qualche fisarmonicista compiacente, ma dai benpensanti era considerato un peccatore. Le brave persone non avrebbero più ballato fino al giorno di Pasqua.
Il giorno delle Ceneri, nel calendario cattolico, è il mercoledì che viene dopo la domenica della Quinquagesima, il giorno in cui inizia il lungo periodo quaresimale. Un tempo (ma questo avviene ancora oggi) in questo giorno ritenuto triste, si bruciavano nelle chiese le palme e i rami di olivo dell’anno precedente e i sacerdoti spargevano un pizzico di queste ceneri sacre sul capo dei fedeli, pronunciando le parole latine “Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris”, e cioè “Ricordati, uomo, che sei polvere e in polvere ritornerai”. Pensiero tratto dal biblico “Libro della Genesi”, 111,19. Iniziavano così i 40 giorni della Quaresima, un periodo in cui la gente doveva pentirsi dei propri peccati.
Tuttavia, qualche giorno prima, in tutta la “Bassa” si festeggiava (e si festeggia ancora) il simpatico “giovedì grasso”, certamente la festa carnevalesca più sentita dalle nostre parti. Era una festa dedicata soprattutto ai bambini, ma anche gli adulti non si potevano lamentare perché il menù tipico di questa giornata prevedeva (e lo fa tuttora) sempre qualcosa di buono, soprattutto sul versante dei dolci. In cucina, per cominciare, si iniziava ad affettare il “salame gentile” (o anche “salame fiorentino”) che era il più grosso e il più pregiato della famiglia dei salami, essendo stato insaccato nella parte terminale del budello del maiale. Non mancavano quasi mai i “maccheroni al pettine”, una pasta alimentare tipica della “Bassa”, che veniva realizzata attraverso un rituale che resiste ancora oggi. Si faceva, da parte della “razdora”, una grande sfoglia, che comportava l’impiego della farina bianca e di un uovo per ogni persona che doveva sedere a tavola: otto persone, ad esempio, e quindi una sfoglia di otto uova. Poi la sfoglia veniva ripartita in piccoli quadretti che venivano quindi arrotolati su piccoli bastoncini usando dei pezzi vecchi di telai usati per tessere la stoffa, in modo che la rigatura del maccherone doveva essere trasversale, e non longitudinale come avviene nella pasta tradizionale, in modo che il ragù si potesse fermare meglio sulla pasta al momento del condimento.
Il ragù nostrano era fatto con carne di manzo tritata, lombo di maiale, salsiccia dello stesso animale, qualche pezzo di lardo, lungamente bollito a fuoco lento per almeno tre ore, con un goccio di vino, carote, sedano, cipolla e altri “odori”.
Sul versante dei dolci, con grande entusiasmo dei grandi e dei bambini, era quasi obbligatorio sia per i ricchi che per i poveri procedere alla preparazione delle “chiacchiere” (in italiano si chiamano frappe) che sono nastrini di pasta dolce fritti nello strutto (adesso si usa l’olio), vale a dire pezzetti di pasta abilmente arrotolata su cui, dopo la frittura, si metteva qualche goccia di grappa e un lieve strato di zucchero a velo, per renderle più croccanti e dolci.
Ma forse la leccornia più tipica del Mirandolese e dintorni in occasione del giovedì grasso erano certamente le frittelle, tanto che in questa zona il giovedì grasso era chiamato anche, in dialetto, “al giuvidì frittlar”, il giovedì frittellaio. Le frittelle potevano essere quelle dolci, quelle di riso e quelle di baccalà, quelle “con l’anima” oppure “senza anima”. Le frittelle “con l’anima” erano normali frittelle contenenti all’interno una fetta di salame, di prosciutto, di coppa o, più spesso, di mortadella. Ma andava molto bene anche una fetta di coppa di testa e non veniva certamente snobbata una bella fetta di “coppa imbastita”. Analoga considerazione veniva portata anche verso i “gnocchi fritti”, che a loro volta potevano essere con o senza “anima”. Possiamo aggiungere, a malavoglia, che l’abitudine alle pizzette e alle “tigelle” non è nostrana e queste due varietà di cibo sono arrivate nella nostra “Bassa” soltanto dopo l’ultima guerra, assieme al “chewingum” e alla Coca Cola.
Ma, sempre in tema di “giovedì grasso” e a proposito di frittelle, è opportuno ricordare che queste non erano razionate in modo rigido, ma esisteva l’abitudine di darne a ciascun commensale “due per ogni orecchio che si contava in casa”, in modo che ogni persona, adulta o bambino, poteva assicurarsi un massimo di quattro frittelle; tuttavia, in modo scherzoso ma non troppo, qualcuno esigeva l’attribuzione di altre due frittelle per ogni orecchio del cane o del gatto; addirittura si arrivavano a contare anche i maiali e le mucche nella stalla. Sta di fatto che di frittelle e di “chiacchiere” non ce n’erano mai abbastanza, nonostante il prolungato impegno delle “Razdore”. D’altra parte il Carnevale bisognava pur festeggiarlo, anche nelle case più povere dove, si diceva, era sempre Quaresima.
Ma la tradizione più classica e più singolare della nostra terra, in occasione del “giovedì grasso” carnevalesco era quella dell’”ungere lo sprocco”, un piccolo grande evento che non trova riscontro in nessun’altra parte d’Italia. Ma per meglio capire il senso (possiamo dire economico) di questa tradizione, praticamente scomparsa soltanto dopo l’ultimo dopoguerra, è necessario fare un bel passo indietro e ricordare che la carne di maiale, e in particolare il lardo biancastro del suino, era uno degli elementi base dell’alimentazione della povera gente. Una bella fettina di grasso suino era un fattore indispensabile per sbancare il lunario alimentare. Il grasso, infatti, serviva a preparare il “soffritto” (che era un po’ il surrogato del ragù) ed era assai frequente, nei minuti che precedevano il mezzogiorno, sentire dalle finestre il caratteristico rumore prodotto dalle “razdore” che “pestavano” il grasso per preparare il soffritto, al quale aggiungevano verdure e “odori”, quali prezzemolo, sedano, carote, aglio e cipolle. Con un modesto soffritto si poteva fare un’eccellente minestra, ricca di quelle calorie che non sempre erano presenti nella dieta della povera gente. Inutile aggiungere che la carne di maiale, oltre che per il suo prezioso grasso, era assai utile anche per i salumi (nella “Bassa”, come vedremo, ne esistevano decine di tipi), per lo strutto, con cui si friggeva, per la carne e per tutto il resto, da cui il proverbio secondo il quale del maiale non si buttava via nulla. Era un fatto reale che le famiglie che avevano la possibilità di macellare un maiale potevano tirare avanti benino per tutto l’anno.
Dopo questa lunga ma forse doverosa premessa (compreso un modesto elogio del grasso suino), va detto che nella nostra “Bassa” c’era la rituale abitudine di andare ad “ungere lo sprocco”: infatti nel fatidico giorno del “giovedì grasso” i soliti gruppetti di ragazzi (ma in questa circostanza erano ammesse anche le bambine), generalmente composti da tre o quattro elementi, preferibilmente dello stesso nucleo familiare, andavano in giro per le case di campagna recitando una filastrocca e tenendo in mano un piccolo ma robusto bastoncino appuntito, detto appunto “al sprocch”. I ragazzini recitavano una breve filastrocca e poi porgevano lo “sprocco”, dove le “razdore” di buon cuore infilavano un bel pezzetto di lardo suino. In questo modo veniva ad ungersi il bastoncino, cioè lo “sprocco”.
La filastrocca era come al solito un po’ accattivante, tuttavia un po’ meno beneaugurante rispetto a quella del Capodanno. Nel Mirandolese recitava così: “A son gnuu a onzar al sprocch/ ch’a min dadi un bel baloch/ Ch’a min dadi un baluchen/ par onzar al mè sprucchen”; l’ultimo verso poteva anche essere “Ch’al mett dentar al mè spurten”. La traduzione in italiano è molto semplice: “Son venuto ad ungere lo sprocco/ che me ne diate un bel balocco oppure un balocchino/ per ungere il mio sprocchino”, oppure “che lo metto nel mio sportino”.
Il bastoncino, ovviamente, era ben levigato, opportunamente privato della scorza e, come si è detto, ben appuntito, mentre le case preferite dai ragazzi erano quelle in cui si era celebrato il rito della “pcarìa”, cioè della macellazione del suino da parte di un esperto “beccaio”. Alla fine della giornata, i ragazzi più fortunati riuscivano a raccogliere un piccolo capitale di lardo suino, che poi veniva avvolto in un panno secco e pulito e “messo in frigorifero” sul davanzale della finestra di cucina, a disposizione della massaia. Per parecchi giorni si poteva fare un buon soffritto.
Poi il Carnevale finiva e arrivava il giorno delle Ceneri e delle penitenze, oltre che il lungo austero periodo della Quaresima. Oggi forse non si ha un’idea precisa di cosa fosse la Quaresima di un tempo, anche perché adesso è sempre Carnevale. Ma nei tempi passati le cose erano meno facili: in primo luogo niente feste danzanti, il ballo era vietato alle ragazze e ai giovanotti di buona famiglia, sconsigliato a tutti gli altri. Il giorno delle Ceneri e tutti i venerdì fino a Pasqua imponevano un regime alimentare di assoluta sobrietà: quindi niente carni, solo pesce, pochi dolci e in qualche casa più bigotta era imposta anche l’astensione dal vino e dai liquori. Si arrivava al punto di astenersi da qualsiasi rapporto carnale anche fra coniugi, mentre invece erano tollerate le trasgressioni fra gli amanti, purché non si sapesse in giro. Tutti i grassi, di venerdì, erano banditi dai negozi di generi alimentari, con deroghe solo per i malati, dietro ricetta medica vistata dal parroco. Inoltre, niente giochi in pubblico, niente caccia e divertimenti in genere. Nel periodo quaresimale (dal latino “quadragesima”, cioè periodo di quaranta giorni), tutto dedicato alla preparazione della Pasqua, esisteva anche il divieto della celebrazione solenne dei matrimoni, se non in casi di assoluta necessità, in compenso nelle chiese si celebrava una vera e propria overdose di “quaresimali”, cioè una serie di prediche che sacerdoti e frati tenevano appunto nei periodi quaresimali. Esisteva infine una serie di predicatori specializzati per questo periodo, chiamati appunto “quaresimalisti”.
E bene o male finiva anche febbraio, con la speranza di qualche nevicata.
Perché nella “Bassa” si pensava che “Nev ad favrar, festa in di granar”.
Tratto da: Antiche Tradizioni Mirandolane
Autore: Giuseppe Morselli
Edizioni Bozzoli
Anno: 2006