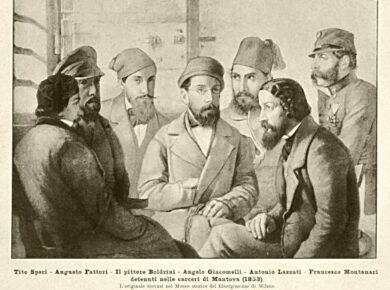Giovanni Pico – La causa di morte: sifilide o avvelenamento?

La causa di morte: sifilide o avvelenamento?
Dopo più di 500 anni, la morte prematura di Pico della Mirandola e quella altrettanto inattesa e misteriosa di Angelo Poliziano continuano ad alimentare la curiosità. I due grandi umanisti morirono veramente assassinati, come hanno sostenuto alcuni, o furono vittima della sifilide che si era diffusa in forma epidemica in Europa proprio intorno agli anni della loro morte, come hanno ipotizzato altri?
La vicenda, comunque, evoca rivalità e gelosie, interessi e intrighi nell’ambito della cerchia delle conoscenze e delle amicizie dei nostri personaggi che investono anche la sfera più intima dei sentimenti e delle inclinazioni personali, soprattutto sulla base di alcuni documenti che sembrerebbero avvalorare l’ipotesi di omosessualità per Angelo Poliziano e nella cerchia delle frequentazioni di Pico. D’altra parte la particolare circostanza della morte improvvisa di Pico a soli due mesi dall’altrettanto repentina morte del Poliziano, preceduta in entrambi i casi da febbri dolorose e stati deliranti, appare quantomeno sospetta. Ci sono dunque buoni motivi per cercare nei resti scheletrici dei nostri personaggi possibili tracce che possano contribuire a far luce sulle cause della loro morte: sifilide o avvelenamento?
La sifilide è una malattia trasmissibile causata da un ceppo di batteri denominati Treponemi. Essa, se non viene adeguatamente curata, evolve normalmente attraverso tre stadi intercalati da periodi più o meno lunghi di remissione della sintomatologia. Nello stadio finale, la malattia provoca danni agli organi interni, al cervello, ai nervi, agli occhi, al cuore e ai vasi sanguigni, al fegato, alle ossa e alle articolazioni. L’origine della sifilide venerea, che ha devastato l’Europa nel Rinascimento, è tuttora discussa. Una prima ipotesi ritiene che la malattia si sia originata in Africa in età preistorica e si sia poi diffusa nei diversi continenti, differenziandosi in diversi ceppi come sembra di poter evincere da numerose fonti storiche che testimoniano l’antica presenza di malattie i cui sintomi sembrerebbero essere quelli della lue, e la identificazione di segni tipici della sifilide su reperti ossei risalenti al XIII secolo, dunque prima dei viaggi di Colombo.
La seconda ipotesi, quella più accreditata, sostiene che la malattia sarebbe stata importata dall’America con uno dei viaggi di Colombo. La malattia sarebbe scoppiata in forma epidemica nel 1493 in Spagna, poi ben presto il contagio si sarebbe diffuso in Francia e in Italia. Qui si sarebbe manifestata prima a Napoli nel 1495; durante il periodo di occupazione francese, poi si sarebbe diffusa rapidamente a tutta la penisola per diffondersi in tutta Europa, in Africa settentrionale e in Oriente.
In Italia la malattia fu chiamata “morbo gallico’’ o “mal francioso” poiché si riteneva che fosse stata portata dai soldati dell’esercito di Carlo VIII. Ma ad indicare la molteplicità dei focolai dell’epidemia, in ogni nazione la malattia fu indicata con denominazioni che ne facevano ricadere su altri la responsabilità: dai francesi fu detta “mal de Naples”, dai portoghesi, africani e olandesi “mal spagnolo”, dai cinesi e indiani “mal dei portoghesi”, dai turchi “mal dei cristiani” e così via. Una recente ricerca basata sul confronto del DNA di 26 gruppi di batteri che causano la sifìlide o malattie simili avrebbe dimostrato che il ceppo di Treponemi che provoca la sifìlide venerea si sarebbe originato recentemente e i suoi “parenti” geneticamente più prossimi sarebbero sudamericani.
E’ noto che la sifìlide, nel suo stadio terminale, può lasciare sulle ossa delle particolari lesioni sotto forma di mammello-nature della superfìcie cranica e incurvamento “a sciabola” della diafìsi tibiale, come del resto, nel caso di avvelenamento, tracce della sostanza tossica utilizzata possono essere rivelate nei tessuti della vittima anche a distanza di molto tempo.
L’esame paleopatologico dei resti ossei di Pico e di Poliziano, anche con l’ausilio di tecniche radiologiche, ha rivelato alcune lesioni di tipo artrosico ma non segni riconducibili alla sifìlide. Ciò non autorizza ad escludere che questa malattia sia stata la causa di morte dei nostri due personaggi in quanto forme acute e fulminanti del male possono non lasciare tracce sulle ossa. Ci potrebbe essere un’altra possibilità per accertare almeno se Pico e Poliziano furono colpiti dalla sifìlide: dimostrare sul loro corpo la persistenza di tracce del genoma del Treponema, il batterio che provoca la malattia. Oggi, con le moderne biotecnicnologie è possibile rintracciare piccoli frammenti del DNA di un organismo e identificare la specie a cui appartiene. Ma l’operazione è molto difficile e le probabilità di avere successo sono ancora molto basse.
Ma, come abbiano accennato sopra, c’è un’altra pista da seguire, quella dell’avvelenamento, una “pratica” non infrequente all’epoca, che veniva eseguita generalmente con l’arsenico. Se i nostri personaggi fossero stati assassinati con l’arsenico si dovrebbero ancora trovare quantità potenzialmente letali di veleno nei loro tessuti.
Allo scopo di effettuare questa verifica, al momento del prelievo dei campioni per la datazione dei resti sono stati perciò raccolti anche reperti per la identificazione e il dosaggio di sostanze tossiche. Inoltre sono stati effettuati alcuni prelievi dalle spoglie di Benivieni utili per il confronto dei dati.
Le tecniche analitiche impiegate sono di tipo microdistruttivo in quanto richiedono quantità minime di materiale. I prelievi sono stati effettuati oltre che dalla cassa, anche in punti diversi delle spoglie dei tre personaggi, in modo da assicurare una repertazione il più possibile differenziata. Sono stati raccolti campioni delle ossa di Poliziano nonché delle ossa, delle unghie dei piedi e dei tessuti mummificati di Pico e Benivieni. Di quest’ultimo è stato repertato anche un piccolo frammento della berretta e del vestito.
Per la esecuzione delle analisi archeometriche sono stati coinvolti il Centro di Datazione e Diagnostica (CEDAD) dell’Università del Salento, che si è occupato delle analisi qualitative volte a dimostrare la eventuale presenza nei resti di elementi che potenzialmente avrebbero potuto provocare la morte di Pico e Poliziano, e il Centro Ricerche ENEL di Pisa che ha effettuato le analisi quantitative finalizzate a determinare il dosaggio delle eventuali sostanze velenose in modo da stabilire se la quantità presente è tale da essere ritenuta letale.
L’analisi con fasci ionici dei campioni, eseguita presso il CEDAD, allo scopo di determinare alcuni elementi chimici maggioritari e in tracce presenti, hanno rivelato innanzitutto una notevole quantità di piombo in tutti i reperti, in concentrazioni da 80 a 300 ppm (parti per milione), ma, accanto a questo dato inatteso, lo strumento ha fornito un segnale attribuibile alla presenza di arsenico anche se la presenza del primo non ha consentito di evidenziare chiaramente quella del secondo in quanto, con la tecnica impiegata, la presenza del piombo maschera quella dell’arsenico. Tuttavia analisi più accurate (effettuate sotto vuoto) hanno evidenziato un segnale attribuibile alla presenza di arsenico al limite della sensibilità della tecnica impiegata.
La presenza di piombo e di arsenico è stata confermata dalle analisi eseguite presso il Centro Enel: l’arsenico è risultato essere presente nelle ossa di Poliziano ad una concentrazione che in un frammento di vertebra raggiunge circa 25 ppm, mentre nei campioni di controllo di individui di oggi non raggiunge 1 ppm; anche sui resti di Pico l’arsenico è presente in tutto il corpo ma in quantità crescenti dal tessuto osseo (5 ppm), ai residui di tessuti molli (7 ppm), alla cute (16 ppm), alle unghie (30 ppm). Le concentrazioni di arsenico nei campioni prelevati dal corpo di Benivieni, che possono essere prese come dosi di riferimento in soggetti normali dell’epoca (dal momento che il poeta fiorentino essendo deceduto all’età di 89 anni è morto quasi certamente di morte naturale) varia da 5 a 10 ppm sia nei campioni di ossa che di tessuti molli, valori decisamente superiori a quelle che si registrano oggi in condizioni fisiologiche (meno di 1 ppm). In base a questi dati, che richiedono comunque di essere ulteriormente approfonditi, nei resti di Poliziano e di Pico, la quantità di arsenico presente risulta essere fino a 25-30 volte più alta rispetto ai valori fisiologici che si registrano negli individui di oggi e significativamente maggiore (3-5 volte) di quella che si è registrata nel corpo di Benivieni.
A questo punto, in presenza di quantità così alte di arsenico rispetto ai valori normali, l’ipotesi di morte per avvelenamento di Pico e Poliziano potrebbe sembrare dimostrata; in realtà, anche se il dato è sicuramente rilevante a sostegno di questa tesi, occorre tenere presente che l’arsenico trovato nei resti potrebbe avere anche un’origine diversa: ad esempio, poteva essere contenuto in medicamenti, in uso all’epoca, somministrati a scopo terapeutico. Del resto da millenni l’arsenico era utilizzato come antisettico per curare le ferite e fino alla scoperta degli antibiotici questo elemento era impiegato nella cura della sifilide e di altre malattie. Dall’altro lato non si può neppure escludere che l’arsenico presente nel corpo di Poliziano, Pico e, sia pure in minor misura nelle spoglie di Benivieni, possa derivare da una contaminazione a cui potrebbero essere stati esposti, nel corso dell’inumazione i resti dei due personaggi. Sono noti casi di presenza nei resti umani di arsenico di origine diagenetica, cioè proveniente da terreni di inumazione ricchi di questo elemento, oppure dal rivestimento metallico del feretro con impurità di arsenico e piombo.
In conclusione, la presenza di arsenico nei resti di Pico e Poliziano, in quantità decisamente superiori al normale, non è da considerarsi di per sé una prova certa dell’assassinio dei due personaggi per avvelenamento. Se però la ricerca storico-documentale individua elementi circostanziali dell’omicidio, i possibili moventi, mandanti ed esecutori dell’assassinio, allora la presenza di arsenico può assumere il significato di prova. In particolare, nell’ambiente in cui viveva, a motivo delle sue doti eccezionali di intelligenza, cultura e bellezza, Pico era certamente oggetto di invidie e poi si era schierato con il Savonarola contro i Medici e ciò gli doveva aver procurato dei nemici. Inoltre non si deve neppure sottovalutare il fatto che Pico era un ricco principe e qualcuno poteva aver interesse ad anticiparne la morte per venire prima in possesso di suoi beni. Ce n’era abbastanza perché più di uno avesse interesse a toglierlo di mezzo.
Tratto da: Peripateticus Miles – Vita, fattezze e morte di Giovanni Pico della Mirandola
Autori: Bruno Andreolli e Giorgio Grupponi
A cura del Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola” – Fondazione Cassa Risparmio di Mirandola
Anno 2009