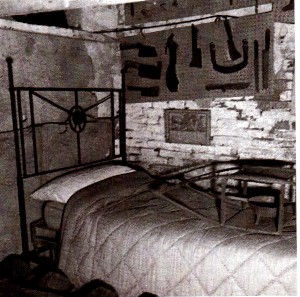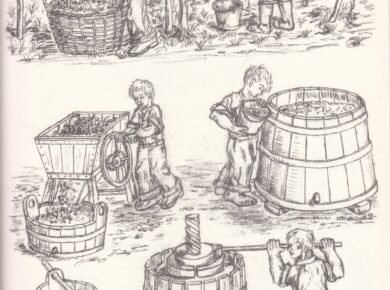A gh’era in-t al let la sora col pret
Era generalmente un’incombenza della razdóra di casa la preparazione dla padlìna dil bras da métar a let, e non si creda che fosse una operazione così semplice.
Occorreva innanzitutto scegliere le braci, bras ad legna forta generalmente d’olmo o di frutto, poi saper creare l’ambiente idoneo affinché si conservassero il più a lungo possibile. Con l’ausilio di paléta e mujet venivano tolte dal camino o dalla stufa a legna (chi avesse conservato quelle fumose “parigine” in terracotta avrebbe oggi in casa un tesoro …),e riposte nella padella (la sòra) al centro di un piccolo mucchietto di cenere preventivamente “scavata a scodella”. Un successivo strato di cenere calda a copertura avrebbe poi garantito una maggior durata della fonte di calore.
Anche “métar al pret a let” richiedeva una certa attenzione, perché bastava la presenza di una piccola scheggia o di un chiodino fuori posto per provocare vistosi strappi nelle lenzuola, a rischio anche di bucarsi o addirittura di andare a fuoco qualora una brace fosse uscita dalla sòra. La coperta, saggiata con il palmo della mano dopo un paio d’ore dall’esperta razdóra, si presentava calda ed un po’ umida, riprova che le lenzuola stavano asciugandosi e cedendo umidità all’esterno (al let as pasàva). In camere gelide, senza nessun’altra fonte di riscaldamento, era quindi una vera goduria immergersi sotto le coltri, tanto che un vecchio detto lo equiparava al piacere di assistere ad uno spettacolo: “andar al teàtar da Bianchin”, si diceva.
I guai seri sopravvenivano se nella notte si presentava l’esigenza per qualcuno di andare in bagno perché, quando c’era, questo si trovava fuori dalle mura domestiche. Largo uso quindi del pitale (al bucalìn), che veniva tenuto a portata di mano nel comodino (anche questo quando c’era) o faceva compagnia sotto il letto alla cassetta di póm campanin e al prete stesso, accantonato per le notti successive. In un ambiente così inospitale per il gran freddo non c’era neppure tanto da indugiare per curare l’igiene intima, cui si assolveva con un catino smaltato, generalmente montato su un treppiede in ferro, talvolta impreziosito da una piccola specchiera. La necessità di lavarsi faceva a pugni con il freddo rigido che non risparmiava nessun locale della casa, tanto che pure la vasca da bagno non era altro che un mastello posto davanti al focolare, nel quale si versavano paioli (i latón) d’acqua bollente preparati dalla razdóra.
Ma riprendendo il discorso sul pret e la sòra, torniamo nella camera da letto, generalmente a cópp a immediato contatto con il tetto della casa, che sovente lasciava intravedere il luccichio di uno spicchio di luna o era attraversato da spifferi gelidi simili a lame affilate che trafiggevano i volti di chi stava nel letto, sepolto da cumuli di cappotti e coperte. I caldi piumoni attuali non sono altro che confortevoli migliorie delle sorpassate “cuèrt ìmbutidi”, ripiene di calda lana che assolvevano egregiamente il loro compito ma che quasi imbalsamavano il corpo di chi vi era avvolto, tanto erano ingombranti e pesanti.
Una alternativa al pret e la sòra era pure al scaldin, contenitore in rame per le braci con un lungo manico in legno, che si introduceva sotto le lenzuola e si spostava varie volte avanti e indietro sino al raggiungimento dello scopo (dar soquanti andàd al let col scaldin). Con l’avvento industriale, nonostante nelle campagne si continuassero ad usare i vecchi “prete e suora da letto”, si brevettò un “prete elettrico”, al centro del quale era posta una resistenza da collegare alla presa di corrente; oggi tutti conoscono inoltre la coperta termica, che in alcuni modelli presenta addirittura un timer di autoaccensione e spegnimento programmati. Nonostante questo, in molti continuano ancora a dire, invitando a predisporre lo scaldaletto: “va’ a tacàr al pret” oppure, in maniera ancora più antica, “va’ a métar a let al fogh”. Per noi finalesi, parlare del “prete da letto”, nonostante non sia più in uso, risulta cosa normale e non si rischia di essere fraintesi. Il “prete” e la “suora” sono oggetti ormai della tradizione passata, che possiamo ora trovare nei mercatini di roba vecchia anche a prezzi di tutto rispetto. Di loro, servitori umili e silenziosi del nostro passato, ci rimanga almeno un simpatico ricordo.
Un racconto di Celso Malaguti tratto da “Il setaccio della memoria” una pubblicazione del Comune di Finale Emilia in collaorazione con il Comune di Cavezzo – anno 2000