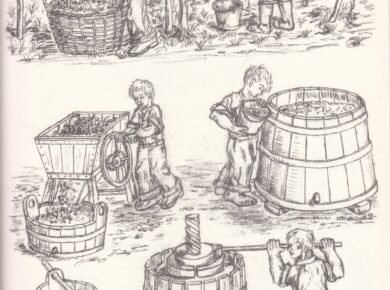1917 – 2017 L’emergenza profughi nei nostri Comuni

Sono passati cento anni dalla disfatta di Caporetto, ottobre 1917. Ben 632.072 civili, friulani e veneti, furono costretti a fuggire dalle loro terre raggiungendo parte della Lombardia scendendo quindi verso Bologna attraversando i nostri territori. Cosa pensare se non “dopo cent’anni la storia si ripete”.
Insieme ai militari sbandati, dopo Caporetto si riversarono all’interno del Paese 480 mila profughi provenienti dalle province di Udine, Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza.
La sconfitta militare e la fuga dei civili colsero completamente impreparate le autorità. A partire dal 27 ottobre il Ministero dell’Interno stabilì che i profughi dovessero essere concentrati in parte a Milano e in parte a Bologna, e da qui essere smistati verso le località di destinazione definitiva; ma a Modena l’arrivo in massa dei profughi fu registrato già quello stesso giorno. I «primi e dolorosi gruppi» di veneti giunsero «all’improvviso e con ogni mezzo di trasporto» il 27 ottobre. Come scriveva la “Gazzetta dell’Emilia” si trattava di «famiglie intere e persone sole», che giungevano a gruppi ed alla spicciolata con ogni mezzo di trasporto possibile. Tutti avevano «bisogno di assistenza e di conforto».
In grandi città e in piccoli centri vennero ospitate sia famiglie di rifugiati che intere istituzioni, come le prefetture, le amministrazioni provinciali e comunali, le opere pie, gli ospedali, gli istituti di pena, i manicomi, i distretti militari, gli istituti di credito e le industrie, che trovarono nuove sedi dove continuare la loro attività.
Alla fine del 1917 si stimava che fossero arrivate a Modena già più di 10 mila persone provenienti dalle terre invase o minacciate dal nemico, che continuarono ad aumentare nelle successive settimane. Complessivamente transitarono per la provincia almeno 30 mila profughi: di questi, circa 7.400 si stabilirono nel capoluogo provinciale e 8.600 in altre località fino alla fine della guerra ed anche oltre. Il censimento dei profughi di guerra dell’ottobre 1918 registrò ancora la presenza, in tutta la provincia, di 9.506 individui, per un totale di 3.082 nuclei famigliari. Un nucleo consistente di profughi trovò sistemazione nella Bassa.
Secondo un censimento effettuato ai primi di marzo del 1918, nei nove Comuni erano complessivamente 1.108, così distribuiti: 13 a Camposanto, 46 a Cavezzo, 47 a Concordia, 284 a Finale Emilia (tutti «completamente approvvigionati», 39 a Medolla, 557 a Mirandola, 90 a San Felice (84 dei quali approvvigionati), 12 a San Possidonio e 20 a San Prospero.
Qualche giorno prima che la sconfitta militare facesse diventare il problema dei profughi una vera e propria emergenza nazionale, era stato emanato un decreto legislativo che organizzava «con criteri uniformi in tutto il regno al fine di renderla più pronta l’opera di assistenza morale e materiale ai fuorusciti delle terre irredente ed ai profughi di guerra».
In ogni Comune in cui si fossero trovate queste particolari categorie di persone era stata resa obbligatoria la costituzione di «uno speciale Comitato locale per la loro assistenza morale e materiale». Questi nuovi organismi locali sarebbero stati coordinati da un comitato centrale istituito presso il Ministero dell’interno. I singoli comitati comunali sarebbero stati costituiti da un decreto del prefetto, che avrebbe determinato il numero dei membri (tre o cinque «a seconda dei casi»). I loro nomi, insieme a quello del presidente, sarebbero stati indicati dallo stesso prefetto, che avrebbe potuto scegliere tra sindaco e assessori del comune, presidente e membri della congregazione di carità e dei comitati di organizzazione civile, persone benemerite del comune «per l’opera svolta nella propaganda patriottica», ispettori scolastici, direttori didattici, maestri comunali, parroci e ministri di culto. In ogni caso avrebbe dovuto far parte del comitato «almeno un fuoruscito o un profugo».
In base al nuovo decreto legislativo questi organismi avrebbero dovuto esercitare nei riguardi dei profughi le stesse «funzioni di assistenza, protezione e tutela» che le leggi e i regolamenti in vigore in Italia assegnavano alle congregazioni di carità nei confronti dei cittadini più poveri.
Nella Bassa uno dei comitati più attivi sorse a Camposanto. Ne facevano parte, tra gli altri, alcuni maestri, il parroco di Camposanto don Renzo Vaccari e quello di Cadecoppi don Angelo Paltrinieri, il capo stazione Umberto Loatti, i presidenti delle Cooperative Braccianti Demetrio Ferraresi e Birocciai Amadio Mantovani ed il nuovo segretario comunale Natale Saladini, profugo proveniente da Musile di Piave.
Con un manifesto del 13 novembre il comitato fece appello alla generosità dei cittadini, raccogliendo quasi 1.150 lire oltre ad «alcuni indumenti».
A Finale Emilia i profughi giunsero soprattutto in due ondate: la prima formata da un’ottantina di persone e la seconda da un centinaio. Al loro arrivo vennero «copiosamente rifocillati» dal locale Comitato di Assistenza Civile ed alloggiati provvisoriamente nella Casa del Popolo e presso alcune famiglie. Solo in un secondo momento i profughi furono sistemati nei locali dell’ex Seminario, appositamente rimesso a nuovo dopo che il lungo abbandono prima e la destinazione a caserma poi lo avevano ridotto in pessime condizioni. In favore di questa nuova popolazione furono raccolte 4.555 lire di offerte, oltre a circa 500 capi di vestiario, suppellettili e stoviglie10. La presenza dei profughi a Finale è testimoniata anche dopo la guerra. Alla data del 13 novembre 1918 erano infatti ancora censite 66 famiglie, per un totale di 222 individui11. A metà novembre un decreto luogotenenziale istituì presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Alto commissariato per i profughi, con il compito «di provvedere all’assistenza morale e materiale dei profughi di guerra» e di occuparsi degli «interessi collettivi delle terre occupate dal nemico». All’inizio di gennaio del 1918 un nuovo decreto luogotenenziale istituì «in ciascun comune, nel quale si trovino profughi di guerra», un «patronato» per la loro assistenza morale e materiale, che di fatto sostituiva i precedenti comitati.
I patronati erano rappresentati ed amministrati da appositi comitati di persone, il cui numero doveva essere compreso tra tre e 15. Anche in questo caso la nomina dei membri e del presidente spettava al prefetto. I membri, che non percepivano alcun compenso e restavano in carica «senza limite di tempo», potevano anche essere donne. Il patrimonio dei patronati era costituito «dai fondi offerti o comunque pervenuti» o raccolti «da ogni persona o ente» a favore dei profughi nella circoscrizione in cui esercitavano le loro funzioni. I compiti di queste nuove istituzioni locali spaziavano dalla verifica del corretto pagamento dei sussidi «alla costituzione e all’opportuno ampliamento di asili e ricreatori per l’infanzia», dal «ricovero dei vecchi e degli invalidi» all’agevolazione dell’acquisto «di generi di consumo», dalla promozione dell’ammissione dei bambini nelle scuole al collocamento della manodopera, dall’assistenza legale al controllo del «trattamento nelle aziende o dovunque» i profughi fossero impiegati. I patronati dovevano anche «ravvivare i rapporti di simpatia e di solidarietà fra essi e le popolazioni», elemento tutt’altro che scontato, visto il progressivo deteriorarsi delle relazioni con il passare dei mesi. Alle autorità locali (Comuni in primis) spettava il compito di garantire ai profughi un primo aiuto alimentare, la sistemazione in locali affittati o requisiti (oppure l’equivalente indennità di alloggio), la concessione di un sussidio giornaliero di mantenimento alle persone in condizione di particolare disagio ed uno per i congiunti sotto le armi. In capo ai Comuni o alle congregazioni di carità era anche l’assistenza medica e sanitaria completamente gratuita, mentre l’ufficiale sanitario comunale avrebbe dovuto vigilare sulle condizioni delle abitazioni, per impedire il manifestarsi o il diffondersi di malattie infettive.
Uno dei principali problemi fu quello del reperimento dei locali. Facendo leva su un sentimento di solidarietà patriottica, la stampa liberale lanciava appelli a tutti coloro che possedevano «una camera, due, un appartamento vuoto, sale superflue nei loro palazzi» per fornire un posto, «restringendosi», a questi «disavventurati»; ma la situazione abitativa, specie nel capoluogo provinciale, era già molto difficile per la popolazione autoctona ed i profughi dovettero spesso accontentarsi di «umide stanze del sottosuolo», «freddi solai», «locali malsani di antica malafama», «peggiori di stalle», dove si ammassavano anche dieci o dodici persone». Le autorità furono costrette a procedere anche a requisizioni forzate.
I profughi appartenevano ad ogni classe sociale. Le famiglie abbienti riuscirono «prontamente ad essere alloggiate in Ville signorili poste in gran parte a disposizione dai proprietari». Alla fine di novembre del 1917 arrivò a Modena da Breganze la famiglia dell’industriale del settore meccanico Pietro Laverda, fondatore dell’omonima azienda. In una lettera dell’8 novembre il figlio Antonio scrisse al collega modenese Taddeo Giusti, chiedendogli di trovare una casa, «possibilmente fuori dalle porte della città alquanto spaziosa e con cortile» per la sua famiglia, composta «da 21 persone compresi i bambini». Laverda aveva mezzi per provvedere alla propria sussistenza, ma la maggior parte dei nuovi arrivati non era in grado di far fronte in modo autonomo alle necessità proprie e della famiglia. In una lettera indirizzata al sindaco di San Possidonio, un profugo con moglie e figlio a carico, che trovò impiego presso una delle fornaci locali, chiese pagliericci, coperte, calderini e persino «un vaso da notte», perché la sua famiglia, «sempre indisposta», era sprovvista di tutto, compresi vestiti e calzature. A Modena come altrove fu particolarmente drammatica la condizione dei bambini che si erano dispersi nella disordinata fuga dalle zone di guerra o che erano stati smarriti dai loro genitori durante il viaggio. La stampa locale diede conto di «turbe di bambini scalzi, laceri, scarmigliati» che vagavano «nelle piazze in cerca non solo del babbo o della mamma, ma pure del tozzo di pane e del vestitino» che li potesse riparare «dalla rigidità della stagione». I bambini senza famiglia o malati ricevettero ricovero ed assistenza in ospizi e collegi, in alcuni locali del castello di Guiglia ed anche in una colonia di Sestola. Il Comitato provinciale profughi si occupò di facilitare l’ammissione dei bambini e degli adolescenti agli istituti scolastici, l’acquisto dei libri e le spese di trasporto21.
Punto di riferimento fondamentale per il coordinamento delle attività di aiuto ai profughi fu il bollettino Pro profughi, organo ufficiale del Comitato (poi Patronato) di Modena, pubblicato tra il novembre del 1917 e l’aprile del 1919. Il periodico, diretto dal Prof. Melchiorre Roberti, aveva una tiratura di 500 copie a numero e usciva con una periodicità quindicinale e con una quindicina di pagine caratterizzate da un corsivo di apertura, una serie di rubriche e vari commenti. Il giornale dava largo spazio alla pubblicazione di lunghe liste nominative dei profughi che avevano trovato una sistemazione, con l’indirizzo degli alloggi presso il quale erano ospitati, e di quelli che erano ricercati perché ancora dispersi. Tramite il giornale le persone e gli enti interessati erano inoltre costantemente informati sull’attività del Patronato e dell’Alto Commissariato per i profughi e trovavano resoconti sulle iniziative parlamentari che riguardavano i diversi aspetti della situazione. Un bollettino con analogo titolo venne realizzato anche a Carpi dal locale Comitato. Il numero 1 fu pubblicato il 15 gennaio 1918. La prolungata convivenza con i profughi provocò continui motivi di malcontento nella popolazione modenese, che ormai da troppi mesi sopportava il peso della guerra e delle privazioni. Dopo l’iniziale partecipazione spontanea e diffusa dei cittadini al dramma dei nuovi venuti, iniziarono a manifestarsi anche diffidenza ed ostilità. L’atteggiamento ostile emerse, ad esempio, in una lettera inviata al suo Municipio di origine, Breganze, da un certo Emilio Domini, ex dipendente dei Laverda, che si disse soltanto desideroso di ritornare al suo «paesello che è tanto bello». Oltre a lamentarsi perché era ancora disoccupato, il profugo deplorò il comportamento dei modenesi, i quali «ci tacciano di profugacci, che mangiano il loro pane e altri simili epiteti che ci rammaricano e umiliano». Tutti gli sfollati conobbero i problemi materiali della vita quotidiana, la difficoltà a trovare un’abitazione, la preoccupazione di ricevere il sussidio, il disorientamento «di fronte ai meccanismi burocratici che regolavano l’assistenza»; ma per le classi popolari e per alcune categorie professionali, come i dipendenti pubblici, l’esilio comportò una marginalità sociale che rasentò l’indigenza.
Molti profughi non riuscirono a trovare un impiego, oppure si adattarono a lavori diversi da quelli che avevano svolto in precedenza e a mestieri malpagati; altri ancora rinunciarono a cercare un’occupazione per timore di perdere o vedersi ridotto il sussidio statale. Con una circolare emanata il 10 gennaio 1918 il governo aveva infatti introdotto un sussidio alimentare a carattere continuativo per i profughi bisognosi, ma aveva anche stabilito che se le entrate di una famiglia, compresi i proventi del lavoro, avessero superato le 600 lire mensili, i patronati locali sarebbero dovuti intervenire per adottare le opportune riduzioni. Vibrate proteste tra i profughi si sollevarono nel giugno del 1918, con la pubblicazione di un decreto luogotenenziale che stabiliva l’introduzione di una tessera di riconoscimento e, soprattutto, la graduale soppressione del sussidio di mantenimento loro assegnato.
Anche i locali ancora «allestiti a carico del bilancio dello Stato ad uso di alloggio» per i profughi delle «terre irredente» e per i cittadini dei Comuni «sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra, ovvero occupati dal nemico» avrebbero continuato a funzionare soltanto per un bimestre, così come le cucine economiche. L’applicazione della normativa fu rinviata alla conclusione delle operazioni di censimento, ma la decisione portò comunque ad una crisi all’interno dell’Alto Commissariato e alle dimissioni dei suoi massimi dirigenti nazionali. In agosto l’ente si trasformò in «organo autonomo di amministrazione centrale», direttamente collegato al presidente del Consiglio e in settembre furono emanate nuove norme per le operazioni di censimento, che affidava ai Comuni l’onere di raccogliere e trasmettere i dati ad una speciale commissione, istituita «presso ciascuna sottoprefettura o prefettura nella cui circoscrizione» risultassero «non meno di 250 profughi». Questa commissione, presieduta dal prefetto o dal sottoprefetto e «composta da due presidenti di patronato e da due profughi membri di patronato nei Comuni che ospitano il maggior numero di profughi nella circoscrizione», avrebbe a sua volta vagliato i dati raccolti e deciso «se e quale misura di sussidio continuativo» sarebbe stata corrisposta ai profughi. Ad ogni modo questa specifica forma di assistenza sarebbe stata concessa solamente alle famiglie «bisognose», ovvero quelle che non raggiungessero un reddito di almeno 200 lire mensili, aumentato di 50 lire mensili «per ogni persona convivente oltre le due». La commissione competente per la Bassa modenese fu costituita alla fine di ottobre del 1918 presso la sottoprefettura di Mirandola. Membri vennero designati il dott. Giuseppe Borellini, il direttore degli Ospedali civile e militare di Mirandola Luigi Silvestrini, il rag. Edgardo Gambuzzi, l’avv. Luigi Zani, il preside della Regia Scuola Tecnica “Calvi” Emilio Castelfranchi (referente per la zona di Finale Emilia), il farmacista Luigi Nannini (per San Felice), il rag. Ugo Bianchi (per Concordia). Presidente era il sottoprefetto di Mirandola, Bartolomeo Lecchi, segretario il rag. Lodovico Franciosi.
Tratto da “Bassa Pianura, Grande Guerra” San Felice sul panaro e il circondario di Mirandola tra il 1914 e il 1918. Autore Fabio Montella anno 2016